postato il 7 Febbraio 2011

La storia della Russia affonda le proprie radici in tempi antichissimi. La cultura di questo sconfinato paese, da sempre un ponte tra due mondi totalmente diversi come l’Europa e l’Asia, si è sempre distinta per la propria terzietà. Una terra attraversata da 11 diversi fusi orari che lambiscono e racchiudono infinite culture, che affondano le proprie radici nei due diversi continenti, ma che in realtà sono terze ed indipendenti.
Dal XVIII secolo in poi, lo sforzo dei governanti russi è sempre stato volto a modernizzare il proprio Paese sul modello delle monarchie europee. Da un lato il tessuto sociale russo, composto in grandissima parte da contadini, garantiva il potere dello Zar e della nobiltà dal malcontento che andava crescendo negli stati in cui l’assolutismo era ormai in crisi. La pressoché totale assenza di una classe borghese salvaguardò la monarchia russa dal pericolo di contagio in ordine agli ideali rivoluzionari francesi del 1789. Dall’altro però condannò per oltre tre secoli il paese ad un cronico arretratezza economica ed in parte culturale.
Sino ai primi anni ’30 del XX secolo, la base economica del paese era rimasta immutata: l’agricoltura era in maniera quasi assoluta il fattore principale. Culturalmente, anche sotto l’impulso di sovrani illuminati come Caterina la Grande, la corte stimolò grandemente la creazione di una “inteligencja”, circondandosi di artisti. Questo fenomeno però porto ad una concentrazione della cultura nelle mani del ceto aristocratico, escludendo in maniera assoluta il mai realmente emerso ceto borghese e precludendo definitivamente la possibilità dello sviluppo di quella coscienza liberale e nazionale che si andava affermando in altri stati europei, ponendo così le basi per l’inevitabile declino di una monarchia mai percepita come garante dello stato.
La Rivoluzione d’Ottobre aprì una fase politica nuova: persino Lenin, nell’importare il modello rivoluzionario marxista, si trovò innanzi a dei limiti considerevoli. Marx aveva infatti preso a modello lo stato dove il liberismo ed il capitalismo avevano già raggiunto un relativo avanzamento (egli infatti era un tedesco e visse per lungo tempo a Londra). Per importarlo in Russia, Lenin dovette stravolgere i propri piani: mancava totalmente una classe di alta borghesia industriale; la ricchezza era detenuta dall’aristocrazia che ancora applicava modelli economici tardo-medievali. La base della lotta di classe non sarebbero potuti essere quindi gli operai, che rappresentavano un numero alquanto esiguo, ma sarebbero dovuti essere i contadini.
Stalin, succedendo a Lenin, comprese la necessità di un adeguamento dell’economia russa ai criteri industriali del XX secolo, sia per motivi strategici (l’indipendenza produttiva russa si era resa necessaria da quando gli stati occidentali, temendo un contagio al proprio interno del morbo del socialismo reale, avevano in pratica chiuso i canali diplomatici e commerciali con l’U.R.S.S.), sia per motivazioni ideologiche (adeguare quindi la società sovietica alla visione marxista). I Piani Quinquennali, alla base di queste politiche economiche, strapparono milioni di famiglie dalla terra per reinsediarle nei grandi complessi industriali, provocando uno shock produttivo in ambito agricolo.
La politica estera sovietica ricalcava il modello dettato da quella zarista, differenziandosi non tanto nei modi, quanto nel fine perseguito. La monarchia russa si poneva come ultima legittimata potenza discendente direttamente da Roma (Czar in russo significa infatti Cesare). Ereditando il trono dell’Impero Romano d’Oriente, il trono di Bisanzio, la corona russa si riteneva di fatto legittimata a difendere gli interessi di tutta la comunità greco-ortodossa e slavofona d’Oriente.
L’Unione Sovietica, differentemente, basava la propria diplomazia sulla convinzione di essere il faro del comunismo mondiale, con il chiaro obbiettivo di esportare le dottrine socialiste ovunque nel mondo. Da ciò presero le mosse varie linee politiche, dal consolidamento dei propri confini con l’instaurazione di regimi satelliti (Dottrina Breznev della “sovranità limitata”), sino allo spiccato Terzomondismo, che consisteva nel fornire aiuti economici e militari a qualunque regime si opponesse all’ “imperialismo statunitense”. Negli anni Ottanta, ciò che il Segretario di Stato Herny Kissinger definì “un gigante miliare ed un nano economico”, iniziò a mostrare i propri limiti.
L’elezione negli Stati Uniti di Ronald Reagan impose una svolta significativa: il presidente varò nel corso del suo primo mandato un poderoso investimento nel settore militare, che ebbe il proprio culmine nel progetto difensivo denominato “Star Wars”. L’Unione Sovietica si trovò costretta ad inseguire gli Stati Uniti nella corsa al riarmo. Gli sforzi sostenuti non le valsero la tanto agognata parità strategica: in compenso aprirono un abisso sul proprio deficit economico.
Agli inizi degli anni ’90 la bandiera rossa fu ammainata dal pennone sul Cremlino. La Russia fu costretta ad un’apertura al mondo occidentale impostale dal proprio ridimensionamento geopolitico a seguito della caduta del Soviet. La Federazione governata da Boris Eiltsin si trovò innanzi un disastro di proporzioni bibliche: a 70 anni di socialismo reale seguì l’introduzione di un liberismo senza regole, che mise in ginocchio una società che, non solo non ne comprendeva le dinamiche, ma che per generazioni l’aveva combattuto. In questo clima nascono le fortune degli oligarchi: spesso giovani figli di funzionari dell’elefantiaco apparato di governo, che sfruttando la posizione sociale all’interno delle stanze del potere, e con l’apporto di capitali spesso di dubbia liceità, riuscirono ad acquistare le aziende di Stato, in particolar modo quelle legate ai processi estrattivi, ad un prezzo irrisorio.
Oltre all’adozione forzata del libero mercato, anche la propria influenza strategica su quelli che sino a due decenni prima erano propri satelliti, venne meno. L’apparato militare, nonostante la oggettiva potenza dovuta anche dai missili strategici, appariva in gran parte obsoleto ed indebolito dal frazionamento dell’Unione Sovietica. Le stesse politiche per l’integrazione seguenti alla caduta del colosso comunista, furono blande e poco convincenti: la Comunità degli Stati Indipendenti sorta a questo scopo non riuscì ad arginare le spinte centrifughe che si vennero a creare all’interno dei singoli Stati membri. In Russia la polveriera caucasica esplose: la Cecenia si autoproclamò indipendente nel 1991, approfittando della situazione di grave incertezza in cui verteva la Federazione Russa.
A seguito del fallimento di ogni iniziativa politica, nel 1994 Eiltsin decise di passare ai fatti, ordinando l’invasione dell’autoproclamata Repubblica Cecena con l’obbiettivo di ripristinare la sovranità russa nella zona. Ciò che seguì fu una disastrosa quanto sanguinosa guerra di due anni, che portò alla sconfitta russa ed al riconoscimento de facto dell’indipendenza cecena. Fu proprio in Cecenia che si giocò la prima e più importante partita del neo Premier Putin.
Nel 1999 un malato Boris Eiltsin lasciò la guida del Paese all’allora Primo Ministro Vladimir Putin; la situazione interna russa si presentava estremamente complessa: sull’onda di un decennio di crisi economica, le periferie reclamavano un’autonomia maggiore dal potere centrale, spesso in maniera violenta. In Cecenia si acuirono le tensioni interne: la lotta per la liberazione e la creazione di un emirato caucasico divampò di nuovo e rischiava di espandersi ai turbolenti territori confinanti.
Il casus belli fu fornito da una serie di attentati terroristici in alcune città russe tra cui Mosca: i servizi di sicurezza non esitarono ad attribuire la paternità delle azioni a dei gruppi di guerriglieri ceceni. Ne seguì come rappresaglia l’invasione della regione del Daghestan da parte dei guerriglieri stessi. Il 26 agosto 1999 si riaprirono le ostilità: le operazioni militari su vasta scala si conclusero nel maggio del 2000, con la presa da parte delle truppe russe della capitale Grozny, già completamente rasa al suolo.
Putin ebbe così modo di consolidare il proprio potere innanzi all’apparato militare, molto influente in Russia e contemporaneamente spegnere le istanze locali di indipendenza che videro nella Cecenia un tragico memento. Iniziò così il decennio dell’Uomo forte del Cremlino. La politica economica, estera e militare russa fu improntata sulla necessità di una revanche sullo scacchiere mondiale: era necessario che la Russia tornasse ad occupare il posto che fu dell’Unione Sovietica e che di diritto le sarebbe spettato nel mondo.
Nel Paese ha acquistato progressivamente consenso l’impostazione definita “Neo-imperiale” del Presidente Putin: riscoprire la grandezza della propria storia attraverso l’iniziativa politica. In materia economica la principale applicazione di questa dottrina politica fu data dall’ondata di nazionalizzazioni che coinvolsero le aziende strategiche controllate dagli oligarchi, giovani che approfittando della propria influenza nell’establishment e con capitali di provenienza spesso oscura, riuscirono ad acquistare la totalità dei comparti estrattivi nazionali.
In particolar modo l’estrazione di carburanti, che ai tempi dell’Unione Sovietica non fu mai sviluppata ai massimi livelli, ha conosciuto negli anni Duemila un boom: il Cremlino ha trasformato così la politica di esportazione di energia nella propria punta di lancia per la penetrazione in Europa. La necessità di approvvigionamento energetico ha reso diversi Paesi nel Vecchio Continente strettamente dipendenti dall’import russo, tanto da arrivare a condizionarne la politica estera. In Europa si sono creati due blocchi. Il primo è composto da nazioni fieramente anti-russe, che vedono nell’imperialismo di Mosca una minaccia storica alla propria esistenza: si tratta di Paesi che hanno subito la dominazione sovietica, come la Polonia o gli Stati Baltici, o tradizionalmente avversi a Mosca sin dalla Guerra Fredda, come il Regno Unito: questi sono i più fedeli alleati di Washington in Europa.
Accanto ad essi vi sono poi Paesi che non hanno mai risentito in maniera diretta o tanto incisiva dell’influenza di Mosca sui propri cittadini ovvero non hanno mai subito lo scontro ideologico violentemente come altri. Si tratta di Paesi che vedono nell’Orso Russo non tanto una minaccia quanto un’opportunità: in questa schiera annoveriamo la Germania, che ha importanti partnership commerciali in campo energetico ed industriale e che ha beneficiato dell’apertura del mercato russo alle proprie aziende, in particolare elettroniche ed automobilistiche. L’Italia negli ultimi anni, a approfondito il rapporto con Mosca sulla base della necessità di una diversificazione energetica che ha portato l’E.N.I. a stringere accordi con la major russa dell’energia Gazprom, pur di dubbia utilità economica.
Vi sono infine Paesi storicamente filorussi, come la Serbia, che è ha ritrovato nella Sorella Russia un appoggio importante, in particolare sulla questione del Kosovo, dopo decenni di gelo tra il Cremlino e Tito; o come la Grecia, che ha rinsaldato i propri rapporti anche nel nome della comune fede ortodossa dopo la ricomposizione dello Scisma tra le due Chiese nazionali.
Le ripercussioni del “divide et impera” energetico sullo scenario internazionale sono molteplici. Il governo russo negli ultimi anni è ricorso più volte al ricatto per poter perseguire la propria politica di rafforzamento in ciò che esso considera una propria area di influenza. Ne è un chiaro esempio l’Ucraina e le tensioni occorse con la Federazione Russa su diverse questioni negli ultimi anni: dal rinnovo della concessione della base navale di Sebastopoli all’avvicinamento all’area N.A.T.O.; in tutti i questi casi, come strumento di pressione il potente vicino ha esercitato il blocco delle forniture di gas al Paese, lasciando di conseguenza senza approvvigionamenti mezza Europa.
La politica estera russa nell’agosto 2008 ha raggiunto un nuovo grado di intensità con l’invasione militare della piccola repubblica caucasica della Georgia. Formalmente il casus belli addotto da Mosca era la violazione di una zona smilitarizzata in Ossezia del Sud, che assieme all’Abkhazia erano sottoposte alla tutela delle forze di pace russe e riconosciute come Stati autonomi solo dalla Federazione. In realtà la partita era ben diversa: in quello stesso anno il Presidente Bush aveva posto le basi per l’allargamento della N.A.T.O. ad Est; era in fase di completamento lo scudo missilistico e le basi radar in Polonia e Repubblica Ceca e la stessa Georgia aveva intrapreso il cammino di partneraniato che l’avrebbe condotta a divenire membro effettivo del Patto Atlantico.
L’Orso Russo, sentendosi stringere intorno alla morsa ha reagito furiosamente: nei delicati equilibri di poteri del Cremlino hanno prevalso i Siloviki, l’area intransigente e militante di cui l’inflessibile Ministro degli Esteri Lavrov è un sostenitore. Ha avuto così luogo la vittoriosa campagna militare georgiana, che ha portato alla luce anche un altro dato: la preparazione militare russa.
Nei primi anni Duemila, inquadrata nella politica di potenziamento nazionale in ogni fronte e supportata dalla crescita economica, lo Stato russo decise di modernizzare le proprie forze armate, in particolare il settore strategico. Nel 2008 lo Stato Maggiore russo ha annunciato le prime prove in mare di sottomarini di nuova generazione della classe Borej, che imbarcheranno il missile balistico RSM-56 Bulava, un nuovo vettore con la capacità di trasportare testate nucleari con una potenza di 500 kilotoni. Nel 2001 a Shanghai, la Federazione ha firmato un accordo di cooperazione militare con la Cina, riavvicinando i due Paesi dopo decenni di gelo diplomatico e stabilendo un’asse alternativo in Estremo Oriente, grazie anche al coinvolgimento di Kazakistan, Kirghizistan, Tagikistan, Uzbekistan e divenendo un interlocutore fondamentale per supporto logistico alla missione I.S.A.F. in Afghanistan.
Con la crisi economica mondiale, l’ascesa dell’Orso russo sulla scena internazionale ha subito tuttavia una violenta battuta d’arresto: tra il 2008 ed il 2009 il p.i.l. russo è calato di circa 400 bilioni di dollari: il 7,9%. Ciò è dovuto sopratutto a causa dell’eccessiva dipendenza dalle esportazioni di idrocarburi, che costituiscono l’ossatura della crescita decennale. Nel corso del 2010 tuttavia, anche grazie all’ascesa dei prezzi dei combustibili, il dato ha subito un’inversione di tendenza, tornando ad un + 4,2% : resta tuttavia la debolezza endemica di un sistema economico eccessivamente sbilanciato nel settore estrattivo.
Ben più preoccupante è il drastico calo demografico del Paese negli ultimi anni, che ha toccato un tasso di – 0,61% nel 2003, mettendo così a rischio la stesso sviluppo nel medio termine. Nonostante ciò, la Russia si presenta come una potenza in divenire, le cui fragili basi economiche e sociali non ne frenano l’ambizione a tornare sul palcoscenico mondiale da protagonista: concentrando la propria attenzione sui Paesi che la circondano cerca infatti di consolidare le fondamenta di ciò che i russi sperano sia il risveglio del grande Orso da un letargo forzato decennale.
“Riceviamo e pubblichiamo” di Federico Poggianti
 In Italia non esiste un dibattito sull’energia nucleare, esiste semmai una guerra, quella sì nucleare, tra i fautori delle centrali nucleari e i partigiani dell’energia pulita. I due fronti invece di confrontarsi e di lavorare per una soluzione cercano di prevalere l’uno sull’altro attraverso le armi non convenzionali dell’emozione: incidenti alle centrali nucleari, crisi petrolifere e così via. Il terremoto che ha colpito e danneggiato la centrale nucleare giapponese di Fukushima e la conseguente “paura nucleare” hanno ringalluzzito gli antinuclearisti di casa nostra che hanno buon gioco a rinvigorire la loro campagna contro il nucleare italiano.
In Italia non esiste un dibattito sull’energia nucleare, esiste semmai una guerra, quella sì nucleare, tra i fautori delle centrali nucleari e i partigiani dell’energia pulita. I due fronti invece di confrontarsi e di lavorare per una soluzione cercano di prevalere l’uno sull’altro attraverso le armi non convenzionali dell’emozione: incidenti alle centrali nucleari, crisi petrolifere e così via. Il terremoto che ha colpito e danneggiato la centrale nucleare giapponese di Fukushima e la conseguente “paura nucleare” hanno ringalluzzito gli antinuclearisti di casa nostra che hanno buon gioco a rinvigorire la loro campagna contro il nucleare italiano.






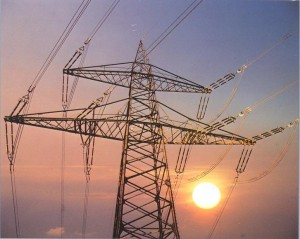






 Facebook
Facebook Youtube
Youtube Flickr
Flickr Blip.tv
Blip.tv Delicious
Delicious Twitter
Twitter Dopplr
Dopplr